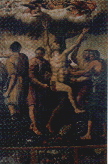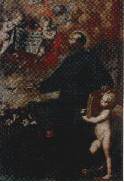Cenni storici sulla Chiesa “Madonna del Carmine” nel borgo antico di Giovinazzo
Sede dell’Arciconfraternita Maria SS. del Carmine e della Redazione del Giornale “in Città”
Le prime indicazioni riguardanti la fabbrica della Chiesa della “Madonna del Carmine”, per lo più come si presenta nell’attualità, con il prospetto principale in via Cattedrale e il fronte di ponente in accosto al sedime della cortina muraria occidentale, su cui corre, oggi, il percorso di via Marina dopo la mozzatura della muraglia medesima, risalgono alla fine del sec. XVI. E, in particolare, le informazioni sull’edificio sacro, dedicato alla Beata Vergine Maria, a memoria dell’apparizione sul Monte Carmelo, in Palestina, al frate eremitico, ottantaseinne, Simone Stock, la domenica del 16 luglio 1251, sono strettamente connesse all’istituzione canonica e relativa attività cultuale e socio-caritativa della Confraternita “Maria SS. del Carmine”. Sodalizio, tuttora, proprietario dell’immobile e la cui fondazione ufficiale risale al 24 gennaio 1598, su disposizione di Mons. Giovanni Antonio Viperano, vecovo della città dal 1589 al 1610, sotto il pontificato di Clemente VIII. Che quel sito, nelle immediate vicinanze della Cattedrale, abbia assunto ben presto, sin dagli inizi del ‘600, un notevole rilievo urbanistico, è dato dal fatto che ebbe ben presto la denominazione di pittagio del Carmine. Tant’è che, a seguito del rifacimento e consolidamento del sistema difensivo occidentale della città, cui contribuiva anche un ampio fossato, approfondito in modo che fosse colmato dalle acque del mare da levante a ponente, il punto bastionato, retrostante la chiesa, fu appellato come baluardo del Carmine. L’opera di fortificazione muraria, messa in atto, sotto il dominio aragonese, dal sovrano Ferrante I e ultimata nel 1488 con il completamento edilizio del torrione cilindrico, “´U Tammurre”, non avrebbe subito, in seguito, alcuna variazione sostanziale e sarebbe rimasta tale se non si fosse intervenuti, già dalla prima metà dell’800, con la parziale demolizione della cinta muraria, una apprezzabile testimonianza di quell’architettura militare cosiddetta di transizione, sperimentata nel Mezzogiorno con il concorso sia di firme prestigiose, fra tutte Francesco di Giorgio Martini, che di valentissimi tecnici locali. Non è, infatti, toccato a Giovinazzo quell’ulteriore evoluzione dei complessi difensivi urbici, introdotta per neutralizzare le nuove pratiche militari di assalto dalla linea del mare e divulgata da una copiosa trattatistica, che consistette nell’integrazione con sistemi bastionati delle precedenti strutture.
“L’area urbica confinata enrto la sua cinta muraria appare in lontananza, in uno sfondo prospettico che include anche zone limitrofe al borgo; di là da essa, a levante, appare pure il mare che profila l’orizzonte solcato dai tipici navigli d’epoca. Lo spazio antistante è quello a Ponente (l’attuale Piazza Vittorio Emanuele II) segnato da sparute emergenze come i magazzini portuali, la cisterna idrica (in vulgo detta “peschiera”), la torre cilindrica a copertura conica ove un tempo sorgeva S. Maria di Porto Salvo con annesso convento francescano. L’agglomerato abitativo, in parte, è proteso verso il mare, con la muraglia e il fossato accentuato da possenti bastionature. Si notano: il “Forte”, all’estremità, e, quindi, la torre del Seggio, sotto il Vescovado, il baluardo del Carmine e relativo Pittagio (cerchiato in rosso), infine, quello cilindico del porto (detto “tamburo”), il bastione della porta di accesso alla città, la torre cilindrica di salita verso via S. Lorenzo, e una delle quattro del fianco meridionale. La cattedrale romanica appare in tutto il suo complesso con gli spioventi delle navate e con le due torri campanarie che svettano verso l’alto. Riconoscibili, altresì, la chiesa di S. Maria di Costantinopoli nella sua forma originaria, la scomparsa Chiesa di S. Felice, l’imponente struttura del palazzo-fortezza della famiglia Spinelli, la Chiesa di S. Maria de lo muro (S. Maria degli Angeli). Appena visibili nel tessuto urbano, le cupole piramidali dello Spirito Santo e, sullo sfondo, l’isola monastica delle “Benedettine”.

Veduta della muraglia sul fronte occidentale della città, alla fine dell’Ottocento dopo l’abbattimento della parte superiore sul cui sedime venne ricavato il tracciato stradale di via Marina. E’ in vista la configurazione del baluardo del Carmine e il retro della chiesa omonima.
Il recente rinvenimento, presso l’Archivio di Stato di Bari, per opera dello studioso locale, Diego de Ceglia, della pergamena del vescovo, mons. Giovanni Antonio Viperano, con cui fu disposta l’erezione dellad Congregazione dei devoti della Vergine del Monte Carmelo, dà modo di avere un quadro certo degli avvenimenti che portarono alla costituzione dell’importante sodalizio, secondo lo spirito dottrinale del Concilio di Trento, ma, soprattutto, all’edificazione della Chiesa dedicata alla Beata Vergine del Carmine. Interessanti, infatti, sono le notizie sul luogo, scelto come sede della Congrega, promossa per volontà precisa di cittadini benestanti, appartenenti a classi sociali altolocate. Nella bolla vescovile è annotato che già in precedenza alla formale autorizzazione canonica del 24 gennaio 1598 era attivo un gruppo di devoti che commemoravano la Visitazione della gloriosa Vergine Maria sul monte Carmelo. Di fatto, in altro documento notarile, datato 15 dicembre 1605, conservato sempre presso l’Archivio di Stato di Bari (ASBa, sk.8 not. D.A.Garofoli, vol. 60, f.31-35) si evince che sin dal 25 dicembre 1596, gli aggregati, praticanti la devozione alla Vergine del Carmelo, erano soliti riunirsi presso la chiesa di San Marco (ormai scomparsa), annessa alla dimora patrizia della famiglia Nicastri e che per le difficoltà ad accedervi e l’angustia del posto fu loro consentito dall’Arciprete Curato di poter utilizzare la chiesa parrocchiale di San Andrea, situata in via Cattedrale. Anche tale soluzione ebbe a rivelarsi del tutto inadeguata, quando i sodali cominciarono a essere più numerosi e non più ospitabili presso l’esigua aula di quella chiesetta. La necessità di quei sodali di avere un sito istituzionale esclusivo e il riconoscimento canonico come Congrega con un ordinamento di vita comunitaria sono di fatto richiamati esplicitamente nella bolla vescovile di erezione del 24 gennaio 1598. La ritrovata pergamena certifica che i confratelli abbandonarono la chiesa parrocchiale di San Andrea avendo, su espresso loro deliberato, ottenuto dal vescovo medesimo di poter erigere la loro sede presso l’antica Chiesa di Sant’Angelo de’ Greci (detta anche di San Michele Arcangelo), dismessa sin dalla prima metà del ‘500, ormai, ridotta a un rudere. Che quel luogo fosse, da qualche tempo, in completo stato di abbandono e di rovina è attestato dallo storico Giuseppe De Ninno (1852-1930) che riferisce dell’utilizzo improprio di quel sito, per essere servito da accampamento e rifugio dei soldati della Compagnia del Capitano Pietro Velez, di stanza in città, per la difesa contro gli attacchi dei Turchi del 1555 (BNBa, Fondo De Ninno, vol. 70/l, f.n.n.).

Foto della Pergamena, datata 24 gennaio 1598, del Vescovo Mons. Giovanni Antonio Viperano, concernente l’atto fondativo e relative “Regule Generali” della Congregazione di Santa Maria dei Carmelitani. (ASBa, atti notarili della piazza di Giovinazzo, sk. 30 not. F.S. Cervone, prot. a. 1805; la pergamena è posta a copertina del volume [A], contenente documenti rogati tra il 1674 e il 1710, conservato presso l’Archivio di Stato di Bari).
Particolarmente indicativa nel corpo della Bolla, a parte la trascrizione delle “Regule Generali”cui devono attenersi tutti i componenti, fissato nel numero di trentatré, è la clausola legale riguardante l’avvenuta cessione della chiesa di Sant’Angelo dei Greci a sede della Congrega, “che dovrà rimanere valida fin tanto non sopravviveranno almeno tre esponenti della stessa”. E’sancito, infatti, che, se si dovesse ridurre ulteriormente il numero dei confratelli, l’immobile dovrà essere devoluto a colui che in quel momento gode del beneficio.
Appena acquisito il possesso della diruta fabbrica della chiesa di Sant’Angelo dei Greci, gli ufficiali
(preposti al governo) del sodalizio tentarono di procedere al recupero edilizio della stessa mediante un intervento di generale ristrutturazione. L’aggravarsi di crolli dalla volta e l’avanzato dissesto degli elementi portanti dell’edificio, tanto da far temere gravi rischi per l’incolumità pubblica, indussero la sodalità ad abbandonare quella scelta e orientarsi per una diversa risoluzione ben più articolata e radicale. Si progettò così di riedificare completamente il tempio ampliandone gli spazi funzionali con l’incorporazione di parte della strada pubblica e di piccoli caseggiati addossati alla precedente costruzione, anche allo scopo di poter utilizzare il soccorpo della costruzione come sepoltura dei sodali. Tanto si ricava dalla lettura del sopra richiamato atto notarile D.A. Garofoli del 15 dicembre 1605 che riporta: “fuit dicta ecclesia manu destructa, et solo equata, et subsequenter fuit designata nova ecclesia quae fuit nimis ampliata quam inveteri erat, et in brevi fuit costrutta”. Sicchè, grazie a sostanziosi lasciti di esponenti di famiglie patrizie, aggregatisi al sodalizio, la chiesa, con il nuovo titolo di “Madonna del Carmine”, già agli inizi del XVII sec., presentava un aspetto del tutto diverso dalla precedente ambientazione della chiesa di Sant’Angelo dei Greci, avendo comportato anche una modifica urbanistica dell’intera zona abitativa. In altro documento notarile del 1615, che certifica alcune contribuzioni di offerenti, sono indicate le misurazioni della nuova edificazione: “ la chiesa in palmi sexanta di lunghezza et in trenta di larghezza con lamie di tufo, oratorio et choro di legno sopra la porta di essa chiesa et sacrestia longa de palmi 24 e larga de palmi 22 con campanile piccolo e campana mezzana”.
Anche gli interni del tempio da subito ebbero a presentare ornamenti, manufatti di corredo liturgico e opere di arredo chiesastico corredate da elementi pittorici di notevole pregio artistico in ottemperanza proprio alle disposizioni testamentarie di sodali benestanti e di munifici devoti alla Beata Vergine del Carmelo. Purtroppo, a partire dal 1615 non si rintracciano informazioni dettagliate sul complesso ecclesiastico del Carmine. E’, comunque, documentato che su iniziativa del vescovo Mons. Giulio Masi (1611-1627) e, in accordo con la sodalità, l’intera struttura edilizia fu ceduta in possesso, comprese le relatve rendite, alla Congregazione dei Padri Somaschi, chiamati in città per assicurare l’indispensabile istruzione sociale e religiosa alla popolazione e agli stessi aggregati alla Congrega cui era permesso ivi radunarsi per adempiere gli obblighi dettati dalle Regole Generali. Permangono del tutto scarse, invece, le notizie circa la situazione della chiesa anche dopo la partenza da Giovinazzo dei Padri Somaschi, nel 1625, mentre sembra si sia continuato a esercitarsi il servizio liturgico, specie dopo la ricomposizione nel 1642 della Congrega della Beata Vergine del Carmine a cura del Vescovo, Mons. Carlo Maranta (1637-1657), cui autorizzò, l’anno successivo, l’affiliazione della stessa all’Ordine Generale dei Carmelitani.
La relazione, concernente la visita pastorale alla chiesa, nel 1695, da parte del vescovo Mons. Giacinto Gaetano Chiurlia O.P. (1693-1730), che appena l’anno precedente l’aveva riconsacrata, a seguito di particolari interventi restaurativi e di esecuzioni di nuove opere ornamentali, contiene apprezzamenti circa l’ordinato stato di manutenzione e di decoro di tutti gli ambienti della stessa:“omnia esse bene disposta e ornata”. Altrettanto positivo è il giudizio trascritto negli atti della visita pastorale eseguita, nel 1737, dal vescovo Paolo de´ Mercurio (1731-1752) che, tra l’altro, raccomanda l’ordinaria tenuta degli arredi liturgici, posti sugli altari, e esprime plauso per il grande decoro riservato alla zona sagrestia che: …“bene aptam invenit illamque laudavit prout circa sacra utensilia solum unum messale suspendit…”. Ancora un importante intervento di miglioria della chiesa è documentato essere stato realizzato, in concomitanza dell’acquisto di un nuovo organo, commissionato al mastro organaro Pietro de Simone la cui installazione comportò modifiche notevoli allo spazio d’ingresso alla chiesa. L’esecuzione di tale opera, descritta nell’atto del notaio G. Riccio, del 17 marzo 1739, conservato presso l’Archivio di Satato di Bari (ASBa, sk 22 vol.386, f.56), consistette nello smantellamento di un arco sull’ingresso per poter realizzare la tribuna orchestrale ove posizionare l’organo “così non solo la detta chiesa verrà pulita, ma anche sarà luminosa, che di presente lume ne scarseggia”.
E’, dunque, da presumere che risale a quel periodo l’apertura del finestrone della facciata e la costruzione della sottostante bussola-cantoria, tuttora, presente e che funge da antiporta al tempio, recentemente restaurata con un’attenta opera di recupero delle decorazioni pittoriche sottostanti alla tinteggiatura dell’impianto ligneo.
Le indicazioni, invece, riguardo all’immobile, sin della prima metà dell’ottocento, non sono per niente soddisfacenti, ancorchè si registra la cerimonia del vescovo Mons. Giovanni Costantini (1837-1852) della consacrazione di un nuovo altare maggiore, che oggi, dopo i lavori ultimati nel 2000, è addossato alla facciata interna posteriore dell’aula. Il manufatto marmoreo risulta essere stato ordinato dalla Congrega già nel 1839 e messo in opera, nel 1841, dall’artigiano napoletano Angelo Rinaldini che l’aveva corredato di due gradini e misurava 13 palmi di lunghezza e 4 e ½ di larghezza, costato ben 160 ducati d’argento. Infatti, da atti di archivio della Congrega si evince che, agli inizi della seconda metà dell’‘800, la situazione dell’immobile era alquanto preoccupante, tant’è che con una delibera dell’assemblea confraternale dell’8 marzo 1851 si convenne l’avvio del progetto volto a dare sistemazione all’immobile che, purtroppo, non andò in porto, nonostante l’approvazione dell’Intendenza di Bari, a causa della mancanza di risorse finanziarie. Ne conseguì, nel 1854, un dispositivo della medesima Intendenza che dichiarò l’inagibilità del tempio e, di conseguenza, la sua chiusura per ragioni di sicurezza, costringendo gli aggregati a frequentare la chiesa monastica delle benedettine per la pratica delle loro azioni religiose.
Per la verità le problematiche che avevano originato la precarietà dell’assetto interno della chiesa erano insorte a seguito dell’abbattimento della cortina superiore della muraglia aragonese cui era parte il baluardo del Carmine e che faceva da muro di confine con la facciata ovest dell’immobile. Un’intensa corrispondenza sull’argomento tra il Comune e l’Intendenza di Bari, nel 1853, rivela la necessità di mettere mano al risanamento di detto muro che creava umidità all’interno della chiesa a causa dell’azione erosiva provocata dai venti da nord e dalle mareggiate cui, ormai, il corpo di fabbrica della chiesa rimaneva esposto, dopo la mozzatura della muraglia di ponente. Solo una consistente elargizione da parte degli aggregati e, soprattutto, il prestito senza interessi concesso dai sacerdoti Giovanni Mastandrea e Tommaso Santoro, anche loro membri della confraternita, resero possibile l’esecuzione dell’interessante opera di risanamento e di rifacimento degli interni del tempio, secondo le linee neoclassiche, per la cui realizzazione ci si avvalse di qualificate maestranze e artigiani restauratori impegnati presso la cattedrale e in altre chiese delle città vicine.
La relazione peritale, a conclusione di detti interventi, redatta nel 1867, dall’architetto Nicola Donato Lariccia, investito dall’Intendenza di Bari allo scopo di chiudere la controversia insorta con il Comune circa i danni subiti dalla Congrega dopo la parziale demolizione delle mura occidentali (in Atti deliberativi della Confraterniata -Restauri alla Chiesa 1855/1895- b.1, f.4), ci rivela che si resero necessari consistenti lavori con modifiche sostanziali alla fabbrica, nel tentativo di bloccare l’umidità sempre più invasiva nell’ambiente sacro. Si dice che fu creata: “un’intercapedine di tufo per coprire per una parte di muro dietro l’altare maggiore, essendosi trovato in pessimo stato…arco e arco di scarico…con muro detto a perpendagno sugli stessi archi anche di tufo carpino…con intonaco a stagnazza fissa fatta al vecchio muro per garantirlo dall’umidità marina”. Nella circostanza fu, altresì, chiuso un finestrone, più esposto a mare, e fu allargato quello sulla facciata principale per permettere maggior luce all’aula, come pure risistemata la porta di accesso alla sacrestia. Si operarono rifacimenti agli arredi dei quattro altari laterali, nonché alla stuccatura dei cornicioni, dei pilastri, che furono arricchiti di scanalature e di capitelli. Tanto lascia presumere che l’umidità infiltratasi nella parete laterale lungo la stradina, che collega via Cattedrale con via Marina, e, particolarmente in quella sul fronte ovest, aveva compromesso interamente le pregevoli decorazioni a stucco che già nel 1778 erano state messe in opera dagli artigiani milanesi Giuseppe e Santino Tabacci ed Andrea Paragalli e dal napoletano Giuseppe Mausco, quando erano intenti ad adornare di stucchi la cattedrale e la chiesa monastica di S. Domenico.
Purtroppo, anche detti importanti interventi di risanamento e di ripristino conservativo, ben presto rimasero compromessi gia sul finire del sec. XIX, come attestano gli atti deliberativi della Confratenità (Delibere del 6 agosto 1893 e del 2 agosto dell’anno successivo), quando si ritenne indispensabile intervenire ulteriormente poiche: “la tettoia è tutta erosa e sgualcita e l’umidità s’infiltra nella volta come nelle pareti attacandone i dipinti e le pregevoli opere d’arte”.
Il fenomeno dell’umidità all’interno dell’ambiente ecclesiale, specialmente lungo la parete di fondo prospicente il porticciolo, e su quella laterale, che fiancheggia la stradina, si fece alquanto rilevante tanto da pregiudicare l’esercizio dei servizi liturgici, interrotti già dalla prima metà del secolo scorso. La chiesa, ormai non più officiata, fu adibita, dapprima, a luogo di attività pastorali della parrocchia cattedrale e di ritrovo degli universitari cattolici e, dagli anni ’70 a scuola di musica dell’associazione locale polifonica, fin tanto che resse la tettoia di copertura dello stabile. Gli ultimi lavori eseguiti dalla Confraternita, alla fine del ‘900, con l’intento di destinare l’immobile a sala convegni e attività socio-culturali, come indicato dalla iscrizione apposta sul lato destro dell’ingresso dell’edificio, pur avendo messo in sicurezza la volta con la completa sostituzione dell’impianto di copertura in legno, non hanno risolto il grosso inconveniente del repentino riaffacciarsi di estesi tratti di umidità sui muri laterali interni. Nuovamente notevole, allo stato, è il danneggiamento delle parti ornamentali in strucco e il deteriorarsi della muratura delle pareti a causa dell’umidità, particolamente su quella esposta a mare. Compromessa, è la cornice in stucco che contorna la pala dell’altare maggiore, raffigurante i Santi Carmelitani e l’apparato marmoreo del sottostante altare che con l’ultimo intervento è stato incassato nella muratura sotto l’arco di scarico, dopo la rimozione dell’intercapedine di tufo realizzata apposta precedentemente per arrestarne le infiltrazioni.
Nell’attualità, infatti, la chiesa, costituita da un’unica navata con sagrestia e annesso ambiente per le attività comunitarie, si presenta spoglia dei quattro altari laterali, rimossi all’inizio della seconda metà del ‘900 per consentire lo svolgimento delle attività pastorali. Come sopra accennato, si conserva solo l’altare maggiore, rivestito di marmo policromo con in basso, in un grande riquadro centrale, lo stemma dell’Arciconfraternita del Carmine, racchiuso in un tondo dai bordi scuri rispetto al suo fondo. Sopra di esso la tela del pittore locale Saverio De Musso (1681-1763) cui è inserita l’immagine della Madonna del Carmine con il Bambino.
All’interno delle quattro arcate inserite sulle due pareti laterali del tempio, ancorchè sguarnite di arredi liturgici, asportati nel corso della seconda metà del ‘900, sono allocate quattro tele artistiche di grandi dimensioni che richiamano la costituzione di rispettive cappelle, erette, nei secoli scorsi, da beneficiari con specifici lasciti testamentari in favore della Congrega.
Sulla parete destra, appena in corrripondenza della bussola sottostante la cantoria, è posta la tela raffigurante il martirio di S. Lorenzo, firmata dal pittore Alonzo de Corduba. L’opera, datata 1602, mostra in basso la figura dell’offerente che sembra voglia invitare lo spettatore a volgere l’attenzione al drammatico evento che vede i carnefici adoperarsi ad appicare il fuoco sotto la grata cui è steso il Santo.
Nell’atto notarile del 15 dicembre 1605, già sopra richiamato (ASBa sk.8 , not.D.A.Garofoli,vol. 60, f.31) viene identificato l’offerente di tale opera nella persona del canonico della Cattedrale, don Iacomo Tomeo, che si dice devoto del glorioso martire Lorenzo e che, in suo onore, ha deciso di erigere nella nuova chiesa della Madonna del Carmine una cappella da dedicare al Santo mediante il dono dell’immagine con relativi ornamenti e la donazione di trentasei ducati al fine di potersi assicurare la sepoltura in detto sito.
Nell’arcata successiva di quella parete è presente l’altra grande tela, raffigurante il gesuita, missionario presso le regioni asiatiche, S. Francesco Saverio, rappresentato in posa dinamica nel suo imperativo protendersi verso una coppia di principi indiani e loro dignitari. Questo dipinto porta in fondo la firma dell’autore: Carolus Rosa pictor Juvenati(en)sis (1613-1673).
L’opera si ipotizza possa essere stata commissionata, nel 1657, dall’Universitas di Giovinazzo, quando la città si era votata al Santo, in occasione della pestilenza che a lungo imperversava. A conforto di tale tesi si richiama l’iscrizione apposta sul paliotto dell’altare ormai scomparso:
«SANCTO FR.CO XAVERIO INDIARUM APOSTOLO OB URBEM EX VOTO SERVATAM».
Agli inizi della seconda metà dell’Ottocento, come sopra esposto, la Congrega diede corso ai lavori di risamento e rifacimento degli interni della chiesa per mettere riparo alle infiltrazioni di umidità nei muri e, in quella circostanza, risulta abbia provveduto anche alla ricostruzione di tutti gli altari, per cui quella lastra con l’iscrizione fu rimossa con gli altri apparati ornamentali. L’iscrizione, ancora al suo posto sotto la mensa dell’altare, fu notata dal concittadiono biografo, Giuseppe De Ninno, che provvide a trascriverla nel suo libro di “Memorie diverse intorno alla città di Giovinazzo” (BNBa, fondo De Ninno, vol. 55, f. n.n.). Notizia, peraltro, confermata dallo storico locale Saverio Daconto (1871-1953) che afferma nella sua “Raccolta di iscrizioni e stemmi esistenti in Giovinazzo”, datata 1888,di averla vista, quando era giovane, accantonata in un angolo del corridoio di passaggio alla sacrestia.
All’interno del secondo arco della parete opposta, prima dello spazio presbiteriale vi è il dipinto effigiante S. Biagio, mentre viene martirizzato, attribuito ai De Musso, Saverio padre (1681-1713) e Giuseppe figlio (1717-1796).
Particolarmente sentita, infatti, era la devozione cittadina verso il martire, e lo è tuttora, alimentata sempre dalla Confraternita Maria SS. del Carmine. Un documento del 1752 testimonia che sin dai tempi della fondazione della chiesa era viva la tradizione, nella circostanza della festività liturgica del Santo, il 3 febbraio, di distribuire, a cura dei membri della Congrega, pezzi di pane a forma di anello e taralli.
Nella prima arcata del fianco sinistro, subito dopo l’entrata della chiesa, è posto il pregevole dipinto, effigiante S. Gaetano da Thiene, fondatore dell’Ordine dei Teatini. Pur non firmato è plausibile l’attribuzione al pittore giovinazzese Carlo Rosa . Il Santo qui è raffigurato in un campo di fiori mentre guarda verso l’alto alla Trinità e al coro degli angeli. Accanto a lui un angelo regge un libro e un calice. Sul cartiglio, sorretto da angeli, si legge: “Ne soliciti sitis animae vestrae quid manducetis respicite volatilia coeli considerate lilia agri”.
Tra i benefattori che, nel corso della fine del ‘600, concorsero a sostenere le spese per l’ammodernamento della chiesa, cui ci dà illustrazione la visita pastorale di mons. Giacinto Chiurlia nel 1695, si registrano i fratelli Prospero e Michele Sagarriga. Costoro, professandosi insieme alla famiglia tutta, devoti di S. Gaetano da Thiene, richiesero e ottennero dalla Congrega di poter avere a disposizione, all’interno della chiesa, una cappella da dedicare al glorioso Santo ove ricavare anche un ambito sepolcrale da riservare per le loro sepolture e per tutti gli appartenenti al loro casato. L’atto notarile del 10 giugno 1699, che fa menzione di tale accordo, convenuto tra la Congrega e i germani della nobile famiglia Sagarriga (ASBa, Atti rogati a Giovinazzo, sk. 16 not. G.F.Graziosi, vol. 247, f.189-193), riferisce del particolare apporto contributivo dato dai due offerenti per rendere la chiesa “con tanta pompa d’oro al pari d’ogni fregiata chiesa, non solo di tutta questa città, ma della provincia, che viene ammirata da chi se sia personaggio che la contempla”.